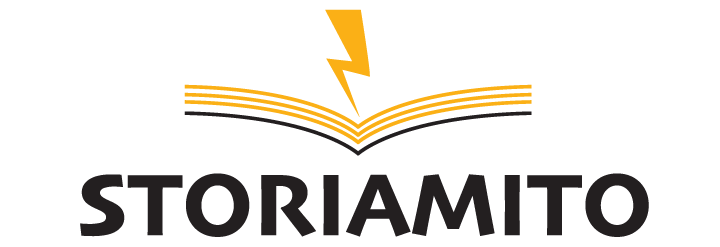Harvard lancia l’allarme con una data precisa per la fine del mondo: scopri il conto alla rovescia che sta già facendo discutere esperti e appassionati in tutto il mondo.
Sulla rete è scattato un nuovo conto alla rovescia: la “fine del mondo” avrebbe una data precisa, venerdì 13 novembre 2026.

A innescare la miccia non è un annuncio ufficiale recente, bensì il riemergere di un celebre articolo pubblicato su Science nel 1960, firmato dal fisico e cibernetico Heinz von Foerster insieme a P. M. Mora e L. W. Amiot, spesso, e impropriamente, rilanciato come “studio di Harvard“.
Il titolo, volutamente provocatorio, era Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026. Da qui il fascino di un countdown virale. Ma che cosa dice davvero quella ricerca? E quante volte, prima d’oggi, il mondo ha già atteso invano l’Apocalisse?
Lo Studio del 1960 e la Data “Maldestra” sulla fine del mondo
Von Foerster e colleghi analizzarono l’andamento della popolazione mondiale con i dati disponibili fino alla fine degli anni Cinquanta. Osservarono una crescita accelerata che, estrapolata con una curva iperbolica, conduceva a una “singolarità” matematica nel 2026: in quel punto, secondo il modello, la popolazione tenderebbe all’infinito e il sistema diventerebbe insostenibile.

Era un esercizio teorico, una provocazione scientifica per mostrare i limiti delle proiezioni meccaniche e per avvertire che, senza correzioni, dinamiche di retroazione positiva (più popolazione, più crescita, più pressione sulle risorse) possono portare a crisi di sistema.
A spingere nuovamente lo studio sotto i riflettori è l’idea, intuitiva e inquietante, che una crescita demografica fuori controllo possa erodere risorse naturali, destabilizzare istituzioni e innescare conflitti.
Gli autori non “profetizzavano” l’estinzione istantanea dell’umanità in una data fatidica: segnalavano un punto di non ritorno teorico, utile a discutere di sostenibilità, pianificazione e scelte collettive.
Letto con gli occhi del 2025, quel lavoro va contestualizzato. La crescita della popolazione globale è proseguita, ma il tasso di incremento si è ridotto rispetto agli anni Sessanta. Molti Paesi stanno sperimentando natalità in calo e rapido invecchiamento: Giappone ed Europa sono i casi emblematici, seguiti da Corea del Sud, Cina e parte dell’Europa orientale.
Secondo le Nazioni Unite, la popolazione mondiale è oggi poco sopra gli 8 miliardi e potrebbe raggiungere intorno agli 11 miliardi entro il 2100, con grandi differenze regionali: l’Africa subsahariana continuerà a crescere, mentre altre aree si stabilizzeranno o caleranno.
Questo non elimina i rischi sistemici. Urbanizzazione accelerata, consumo di suolo, perdita di biodiversità, stress idrico, crisi climatica ed energie ancora largamente fossili comprimono il margine di sicurezza planetario.
Non è tanto un’imminente “esplosione demografica” a suggerire scenari catastrofisti, quanto la combinazione fra uso inefficiente delle risorse, disuguaglianze crescenti e fragilità istituzionali. In questa luce, il “venerdì 13” di von Foerster resta un monito: senza governance e innovazione sostenibile, le curve possono piegarsi nella direzione sbagliata.
Le “Fine del Mondo” che non furono
La fascinazione per un giorno X, scolpito sul calendario, accompagna la modernità. Ecco alcune tappe in cui si attese invano l’Apocalisse: nel 1910, la cometa di Halley fece temere l’ingresso di gas tossici nell’atmosfera. Nel 1954, i “Seekers” di Dorothy Martin annunciò la fine imminente e l’arrivo dei dischi volanti. Nel 2000, il “millennium bug” (Y2K) spinse governi e aziende a corpose correzioni preventive. Nel 2012, interpretazioni fantasiose del calendario Maya furono scambiate per una scadenza cosmica, fissata al 21 dicembre.

Questi episodi mostrano un copione ricorrente: una data evocativa, un nucleo di dati o paure legittime, un’interpretazione sensazionalistica e, spesso, un esito che smonta la profezia senza però cancellarne il fascino popolare.
Sui social pullulano timer che scendono verso il 13 novembre 2026, playlist apocalittiche e post che attribuiscono a “Harvard” un annuncio ufficiale. In realtà nessun ente scientifico ha proclamato la fine del mondo.
È riemerso un classico della letteratura scientifica, utile a discutere di limiti, resilienza e scelte collettive. I demografi ricordano che la transizione demografica è in corso e che i fattori decisivi per il benessere globale saranno riduzione delle disuguaglianze, efficienza nell’uso delle risorse, innovazione pulita e istituzioni capaci di gestire shock e rischi complessi. Nel frattempo, la data resta lì, più come specchio delle nostre ansie che come appuntamento con il destino.