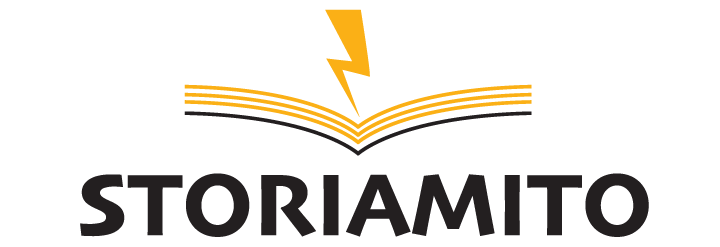La legge che rivoluziona il consenso sessuale : per ogni rapporto sarà necessario un consenso scritto. Ecco cosa cambia e come questa norma mira a proteggere la libertà e la sicurezza non solo delle donne ma di tutti.
Dopo la sentenza di primo grado sul caso Ciro Grillo, la discussione pubblica sul consenso sessuale è riesplosa con toni incandescenti.

Un lancio di agenzia ha rilanciato l’ipotesi, attribuita a Laura Boldrini, di un “consenso scritto della donna prima di un rapporto sessuale”.
Nello stesso solco, la senatrice dem Valeria Valente ha rivendicato la necessità di una legge che definisca in modo esplicito il perimetro del consenso, “libero, consapevole, esplicito e continuato”, richiamando la Convenzione di Istanbul.
L’idea ha scatenato immediate reazioni: tra chi la considera uno strumento di civiltà giuridica e chi la bolla come un “green pass dell’amore”, un eccesso di burocratizzazione dell’intimità.
La scossa arriva all’indomani della decisione del tribunale, che ha giudicato stupro il rapporto avvenuto a Porto Cervo, affermando implicitamente un principio chiave: senza consenso non c’è sesso, c’è violenza.
Per Valente, una riforma codificata aiuterebbe le vittime nelle aule di giustizia, riducendo zone grigie interpretative e affermando una cultura dell’affermazione, non del silenzio.
Il Partito democratico, ricordano dal gruppo parlamentare, ha già depositato testi alla Camera e al Senato per introdurre una definizione legale del consenso come elemento centrale del reato.
La legge per essere al sicuro: servirà il consenso scritto della donna
Ma il nodo che incendia il dibattito è l’ipotesi del “consenso scritto”. I critici parlano di uno scenario grottesco: due adulti che, nel pieno di un’intesa, si fermano a firmare un modulo prestampato.

Chi solleva dubbi pone questioni pratiche e giuridiche: quando dovrebbe essere rilasciata la dichiarazione? Prima, durante, dopo? E come garantire che il consenso resti “continuato”, visto che può essere revocato in qualsiasi momento? Esisterebbe il rischio che un foglio firmato diventi uno scudo improprio in mano a chi voglia abusare, nonostante un cambio di volontà intervenuto nel corso dell’atto.
Sul piano comparato, i modelli esistenti indicano direzioni diverse. In Svezia, la cosiddetta samtyckeslag ha spostato l’asse sulla necessità di un consenso esplicito, ma non richiede alcun modulo scritto; in Regno Unito, la giurisprudenza valuta se l’imputato avesse una “ragionevole convinzione” del consenso, sulla base di circostanze e comportamenti, non di carte.
Perfino le sperimentazioni di app per “firmare” il consenso hanno incontrato critiche diffuse tra giuristi e associazioni femministe: la natura dinamica dell’intimità non si lascia racchiudere in una schermata, e ogni consenso deve essere libero, informato e revocabile all’istante.
In Italia, l’articolo 609-bis del codice penale già punisce la violenza sessuale. La domanda che si pongono i giuristi è se inserire la nozione esplicita di “assenza di consenso” nelle norme possa rendere più lineare la prova dibattimentale, evitando di far ruotare tutto su resistenza fisica, minaccia o capacità di opporsi.
I sostenitori della riforma vedono in questa cornice un aiuto per le vittime, spesso sottoposte a controesami intrusivi sulla loro condotta precedente o successiva al fatto. I detrattori temono invece che una versione “burocratica” del consenso, specie se declinata come dichiarazione scritta, snaturi l’esperienza amorosa e generi contenziosi su moduli, timestamp, messaggi, piuttosto che sui fatti sostanziali.
Resta anche un profilo di opportunità politica. La proposta firmata Boldrini difficilmente troverebbe numeri sufficienti nell’attuale legislatura, dove le forze di maggioranza mostrano freddezza verso ulteriori fattispecie penali o nuovi adempimenti.
La stessa Valente richiama l’urgenza di norme chiare, ma ammette che il confronto dovrà misurarsi con una sensibilità pubblica divisa fra tutela delle persone e rifiuto della “carta bollata” nella sfera privata.

Una possibile linea di mediazione, evocata da alcune accademiche, sarebbe distinguere tra principio e strumento: sancire in legge che senza consenso non c’è rapporto, definendo il consenso come affermativo e revocabile, rafforzare la formazione di magistrati e forze dell’ordine, incoraggiare l’educazione affettiva nelle scuole, e lasciare al giudice la valutazione di tutte le prove, comprese eventuali comunicazioni scritte tra le parti, senza trasformarle in un requisito formale.
La discussione, per ora, oscilla tra l’immagine caricaturale del contratto sul comodino e la richiesta di certezza giuridica dentro e fuori l’aula, specchio di un Paese che fatica a conciliare desiderio e diritto.